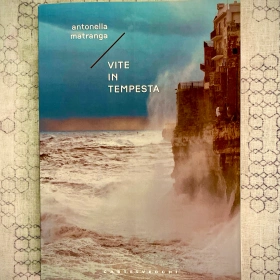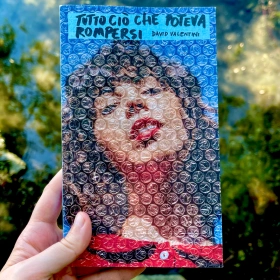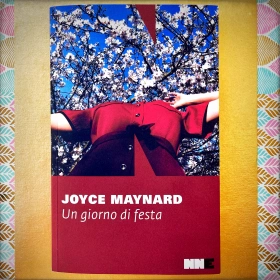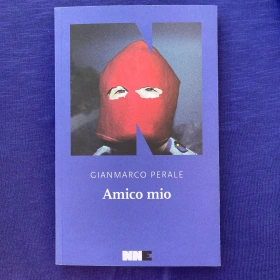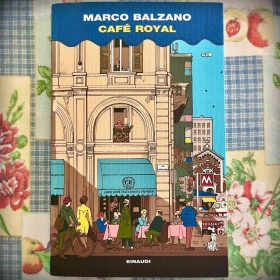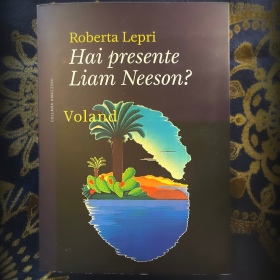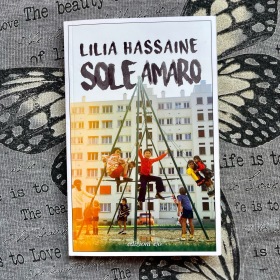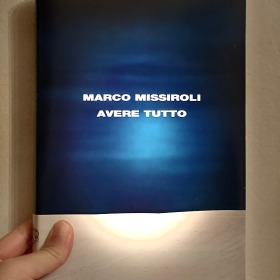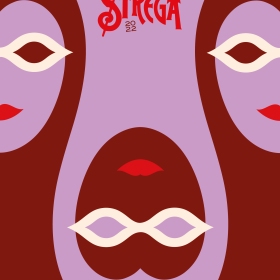Emanuele Trevi con “Due Vite”, edito da Neri Pozza, ha vinto la LXXV edizione del Premio Strega. La serata ha avuto luogo, come da tradizione, a Roma al Ninfeo di Villa Giulia, sede del Museo Nazionale Etrusco ed è stata trasmessa in diretta su Rai 3 e condotta da Geppi Cucciari.
Piacevole il ritmo televisivo della finale, il cui svolgimento è stato inframezzato dalle abituali cartoline di illustrazione dei libri finalisti da parte degli autori, poi intervistati dalla Cucciari. Da segnalare l’idea delle clip (a cura di Emilia Zazza) in cui alcuni bambini provano ad immaginare il contenuto dei libri finalisti dalla copertina: le loro suggestioni sono frizzanti, fresche, innocenti e spesso profonde. Una bella trovata, riuscita, per stemperare l’atmosfera della serata, rendendone il flusso più brioso. Ma passiamo al cuore degli accadimenti.
Questa la classifica finale della cinquina 2021:
- Emanuele Trevi – “Due Vite” – Neri Pozza – 187 voti
- Donatella di Pietrantonio – “Borgo sud” – Einaudi- 135 voti
- Edith Bruck – “Il pane perduto” – La Nave di Teseo – 123 voti
- Giulia Caminito – “L’acqua del lago non è mai dolce” – Bompiani – 78 voti
- Andrea Bajani- “Il libro delle case” – Feltrinelli – 66 voti
Le parole dei protagonisti

Emanuele Trevi “Quando ho iniziato a scrivere “Due Vite” non avevo un progetto preciso, ma davanti quest’immagine dei miei due amici scrittori, Rocco Carbone e Pia Pera. Mi interessava vedere queste due persone dentro un aspetto di realizzazione artistica e dentro un altro, precedente, di incompleta incertezza del futuro. Scrivendo, ho notato che ho avuto maggiore facilità di trattamento del maschile, della parte su Rocco. Egli aveva un’idea della scrittura molto sobria e severa, la realizzava anche impiegando poche parole. La psiche di Pia, invece, presentava due caratteri che possono sembrare contraddittori: il culto della realtà come materia modificabile e quello del gioco, in cui trasformava il lavoro sulla realtà.
Abbiamo piantato un albero per ricordare Rocco e la cosa incredibile è che questo è un gesto connaturato alla vita di Pia, come se fosse un pezzettino del suo giardino: è un monumento vivo e cresce nel tempo insieme a noi. Non è importante creare l’eterno, l’importante è allungare la memoria. Nel libro parlo anche di mie mancanze, perché i libri sono anche riparazioni: nel momento in cui vivi qualcosa, non ti rendi mai conto del valore di chi hai di fronte. Non avevo percepito, come invece lo faccio ora, la bellezza di queste due persone: poi li amavo tantissimo e son stato fortunato perché con entrambi abbiamo fatto in tempo a dirci che ci volevamo bene. Mentre scrivevo la parte su Pia, sentivo come un consiglio da parte di questo suo fantasma che mi diceva di non correre a conclusioni affrettate, invitandomi a ragionare su quanto avrei detto su di lei: è stata una sorta di rallentatore.
Pensare o sognare qualcuno è una proiezione, invece se ne scrivi, semplicemente perché è una grandissima rottura di scatole fra virgole e congiuntivi, mortifichi il tuo ego e quindi appare, con una specie di sua propria volontà la persona assente che ti manca . Il motore della scrittura è proprio la mancanza”.
Donatella Di Pietrantonio “Borgo Sud” è un romanzo sulle conseguenze del disamore. Le due sorelle già protagoniste de “L’arminuta” attraversano la vita adulta, ancora condizionate dal vuoto degli affetti familiari vissuti nell’infanzia e adolescenza.
Quello che è accaduto a me quando sono arrivata a Borgo Sud a Pescara è quanto succede nella finzione anche ad Adriana: siamo state accolte. Ho subito sentito fortissimo lo spirito della comunità che abita il borgo; così, da ambientazione, Borgo Sud è diventato titolo ma anche protagonista del romanzo. Qui è tutto più lento, più umano.
Sento che le voci di questi personaggi, stavolta, dentro di me si sono placate; sono pronta per nuova storia.
Per me è molto importante lasciare uno spazio in cui il lettore possa mettere del suo, perché nella mia dimensione di lettrice trovo molto fastidioso quando un libro mi insegna tutto, come un piatto già completo, mettendomi in una posizione passiva. Ho bisogno mi si lasci una zona di libertà ed immaginazione e, quindi, cerco di farlo anche nella scrittura.
All’inizio, scrivere questo libro è stato difficile: la svolta è arrivata quando ho spostato in avanti il punto di vista, con una voce più matura, più vicina all’età di mezzo che io stessa sto vivendo.”

Edith Bruck “Il pane perduto” è una specie di favola in bianco e nero; favola in nero e favola a colori. Inizia nel ’44 nel mio villaggio ungherese, dove poi arrivano i gendarmi ungheresi fascisti e deportano tutta la mia famiglia e l’intera popolazione. Andremo ad Aushwitz e in altri sei campi diversi di lavoro e annientamento, passando da un’infanzia povera ma felice, alla lotta per la sopravvivenza. Ho poi cominciato peregrinare per mezza Europa alla ricerca di un nido, un Paese dove poter vivere e restare. Nè in Ungheria né in Europa c’era accoglienza: eravamo un peso per noi stessi e per gli altri. Non volevano ascoltarci. Ero gonfia di parole: scoppiavo, se non avessi parlato, sarei impazzita.Sono arrivata nel ’54 in Italia e ho avuto un unico pensiero, mi sono detta: “Qui posso vivere”.
Poi ho incontrato l’uomo della mia vita e abbiamo visto insieme per sessant’anni. Quando mio marito si è ammalato di Alzheimer, l’ho curato per dieci anni da sola con grandissima dedizione. Forse sono stati, anche se pare paradossale, gli anni più felici della mia vita, perché non mi ero mai sentita così importante per qualcuno. Anche se molto faticoso, è stato un periodo di grande amore, ma forse tutte le cose belle sono faticose.
Lentamente, ho imparato l’italiano e attraverso questa lingua ho potuto scrivere ciò che mi pesava e premeva dentro. Penso che testimoniare e raccontare ai ragazzi quello che è accaduto sia sempre attuale e importante, perché nelle scuole lo si insegna poco e male. Riguarda più gli altri che noi che abbiamo vissuto qualcosa di indicibile, il loro futuro.
Ne “Il pane perduto” ho scritto una lettera a Dio: mi lamento, chiedo, cerco, esprimo dubbi e incertezze, ma ringrazio il cielo perché mi ha salvata dall’odio.
Ho scritto questo libro per ripercorrere la mia vita e la tredicenne che sono stata e che vive, agisce, ride e piange in me; ma non passo la vita a piangere sul passato, faccio molte cose per il presente e per gli altri.
Non ho avuto figli, ma i miei libri sono i miei figli: sono molto carnale, scrivo prima nel grembo e poi tutti a mano; c’è un rapporto molto corporale fra me e la penna.”

Giulia Caminito “Il mio libro è un romanzo di formazione e deformazione, raccontato in prima persona dalla protagonista, Gaia, che proviene da una famiglia difficile con problemi economici. La sua voce ci racconta l’adolescenza trascorsa fra l’avere e il non avere e noi la seguiamo fino al momento in cui dovrebbe entrare nell’età adulta. Ho scelto il lago di Bracciano perché volevo immergermi in una realtà a me nota e mi sembravano interessanti anche le metafore che poteva evocare: in Gaia c’è qualcosa di sommerso, nel modo in cui costruisce e decostruisce la propria identità.
A marzo 2020, in pieno loockdown, stavo terminando la stesura, ma mi sembrava di stare facendo qualcosa di inutile in quel momento; pensare a un libro nel mondo con le librerie chiuse è stato un momento assurdo per me. Poi, dato che mi mancava la fine ed ero casa, mi sono concentrata e l’ho terminato. Il racconto segue le tappe di un romanzo di formazione: seguiamo le varie tappe della vicenda della protagonista in cui potrebbe crescere, evolvere, formarsi, ma in realtà non fa altro che scalciare, aggredire, cadere. Il libro ha un’organizzazione circolare: è come un gioco dell’oca in cui lei sbaglia la casella venendo rimandata al via.
Ho provato a parlare di qualcosa che riguarda le persone della mia età: quella difficoltà di accedere a qualcosa, quei tentativi di rivoluzione che poi non arrivano, la voglia di cambiare totalmente la propria vita per ritrovarsi con i piedi un po’ nel fango. Questo è sicuramente ciò che io e Gaia condividiamo di più.”

Andrea Bajani “Nel libro penso di aver utilizzato la lingua esattamente come faccio quando scrivo poesia: prima di tutto si va dietro ad una musica, a un suono. Questo romanzo, costruito per istantanee che si muovono per tempo e spazio, per me è come fosse un poliziesco dell’identità. L’unica possibilità per rincontrare ciò che sei stato, è andare nella casa in cui hai avuto sedici anni, costruendo un’architettura di indizi sulla base della quale il lettore è chiamato ad intervenire. Scrivere questo libro per me ha significato accettare e prendermi cura di tutto gli “Io” che sono stato e se non sono stato un buon “Io” pazienza, ance quello ha comunque diritto di cittadinanza in questo testo. Mai, però, fare ordine: sennò cosa a scrivi fare?!
Quando scrivo, penso che nessuna frase inutile ebba essere inutile, stando lì “tanto per”: ognuna deve essere significativa, importante, degna. Ecco perché si capisce perché ci metto anche sei anni a realizzare un libro.”